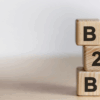Il ruolo del turismo e della conoscenza nel contesto geopolitico. La fiera del Turismo di Teheran.
Mentre in Italia si conclude il BIT 25, a Teheran (Iran), si inaugura la 18° edizione della TITE – la Tourism and related Industries exhibition.
Si tratta di una fiera molto importante per la regione, che, stando a quanto si apprende dai documenti ufficiali, nel 2025 tenderà ad ospitare più di 15.000 visitatori, 700 espositori, 70 workshop e almeno 15 nazioni rappresentate.
La fiera, che ha sicuramente un’estensione inferiore al BIT, che nel 2025 ha ospitato più di 1.000 espositori provenienti da 64 differenti nazioni, presenta tuttavia degli argomenti di riflessione che dovrebbero far riflettere, a partire proprio dalle nazioni ospitate.
I Paesi che parteciperanno alla TITE, infatti, sono Malesia, Russia, Indonesia, Tailandia, Armenia, Turchia, Tunisia, Iraq, Tajikistan, Zimbabwe, India, Uzbekistan, Vietnam, Tanzania, Kyrgyzstan, Kuwait e Cuba.
Visti nel loro complesso, definiscono una geografia turistica in parte differente dall’insieme di connessioni che siamo soliti immaginare in ambito turistico, così come tra l’altro dimostrato dalla presenza, alla TITE, di diverse nazioni che invece non sono state ospitate presso la Fiera di Milano: assenti tra gli stand di Rho Fiera erano Malesia, Russia, Indonesia, Iraq, Zimbabwe, Tanzania, Kyrgyzstan e Kuwait. Per dirla in numeri, delle 17 nazioni indicate nei comunicati stampa della TITE, quasi la metà di esse non era rappresentata ai nostri stand.
Si tratta di una condizione peculiare, che propone una dimensione turistica alternativa alle tratte che, guidate da accordi e reciproci impegni pubblici e privati, può avere un forte impatto sugli equilibri turistici del futuro.
Soprattutto spicca l’assenza dell’Italia dalle nazioni citate, condizione che, di base, dovrebbe essere sempre scongiurata: con un fatturato derivante dal turismo sempre più rilevante per la nostra economia, l’Italia ha bisogno di mantenere relazioni internazionali in qualsiasi fiera del mondo riguardi il turismo, soprattutto in un periodo storico come questo in cui, nei prossimi dieci anni, si deciderà se l’Italia si troverà a vivere in un mondo multipolare (condizione che pare sempre più evidente sia sotto il profilo economico, che culturale) o se si ripristineranno le condizioni oligopolistiche a trazione statunitense e “occidentali” (condizione che tuttavia pare possa avverarsi soltanto con una forte interruzione delle tendenze in atto).
Nel nostro Paese sono poche le riflessioni che l’avvento sempre più esplicito di un multipolarismo potrà avere sul nostro settore turistico: si punta ad ottimizzare i trend, a trovare sempre nuovi hashtag, a sviluppare servizi tecnologici e digitali, e a migliorare il posizionamento sui mercati primari di turismo in incoming. Elementi senza dubbio essenziali sotto il profilo congiunturale, che stimolano la domanda attraverso nuovi “prodotti” (se fa troppo caldo si punta sulle mete montane) o organizzare in modo più efficiente elementi già esistenti (il turismo medicale, il turismo del benessere, e via discorrendo).
Sono però azioni di corto raggio, che non prevedono, ad esempio, che altri Paesi possano prendere il nostro posto attraverso lo sviluppo di investimenti in sicurezza, in infrastrutturazione turistica e in posizionamento strategico globale.
Si tende a pensare che l’Italia sarà sempre una meta turistica. Si tende anzi a ridurne l’afflusso, per evitare fenomeni come l’overtourism, hashtag molto inflazionato che tuttavia è da ricercare più nell’incapacità del territorio di creare un’offerta adeguata che ad una effettiva “eccessiva domanda”.
La definizione dell’overtourism come “problema” è essa stessa una riprova del fatto che l’Italia immagini il suo podio turistico come strutturale. Dovuto al cibo, al benessere, alla cultura, alla grande attrattività che l’Italia esercita oggi sul mondo.
Uscendo da una visione italocentrica, tuttavia, è un dato di fatto che nel mondo ci siano Paesi che sul lato gastronomico, paesaggistico, culturale e storico hanno dotazioni patrimoniali molto consistenti.
Si prenda l’Iraq, che sorge in quello che è stato dimostrato essere uno dei crocevia più importanti non solo delle civiltà, ma anche prima, delle grandi migrazioni che l’homo sapiens ha avviato millenni prima delle grotte di Lascaux, e forse ancor prima della speciazione che ha portato poi all’emersione dei Neanderthal. In un territorio così longevo è naturale siano presenti elementi culturali di grande rilevanza (Assur, area archeologica iscritta nella lista Unesco, risale al III millennio a.C.), ma sono moltissimi i siti degni di interesse, in cui l’Italia è presente anche attraverso azioni finanziate dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), che ha contribuito alla costituzione del parco archeologico di Sennacherib, finanziando le attività dell’Università degli Studi di Udine guidate dal Professor Daniele Morandi Bonacossi, che del progetto ne è il Direttore.
Si tratta soltanto di un esempio che dimostra come l’emersione di altre nazioni all’interno dei flussi turistici globali possa essere concretamente possibile, soprattutto in quelle aree che, per posizione geografica, vantano una centralità “alternativa” alla nostra.
Di fronte a tali evidenze, quindi, risulta forse doveroso avviare qualche riflessione più approfondita sul ruolo turistico dell’Italia, e su come l’influenza turistica dell’Italia nel mondo, richieda da un lato azioni di “mantenimento” (più che di effettivo disincentivo), e dall’altro possa essere uno strumento importante nella costruzione di legami importanti con aree geografiche e regioni che, nei prossimi anni, potrebbero divenire sempre più “distanti”.
In questo contesto, l’avvio di connessioni economiche, accanto alle già esistenti connessioni accademiche, potrebbe avere un ruolo molto importante nella creazione di rapporti duraturi e diffusi, andando ad agire sotto il profilo diplomatico, ma anche sugli effettivi scambi commerciali.
Iniziare a considerare dunque il turismo, e l’insieme variegato di conoscenze, prodotti, servizi, relazioni e network, come un effettivo e composito strumento di connessione geopolitica, soprattutto alla luce dei cambiamenti in atto, potrebbe rappresentare una scelta vincente nel medio periodo.
In alternativa, però, possiamo aspettare pazienti l’avvento del prossimo hashtag.